di Ivano Mugnaini
Ci sono libri che gli autori scrivono per gli altri allo scopo di gratificare loro stessi. E ci sono i libri che gli autori scrivono per prima cosa per loro stessi. Gli altri ci sono, perché è così e non può essere diverso da così, ma l’impressione, leggendoli, è che chi li ha scritti lo abbia dovuto fare, perché ne aveva bisogno, come si ha il bisogno a volte di aprire la finestra e prendere una boccata d’aria, oppure di salire sulla macchina e andare verso un bosco, più lontano e isolato possibile. Ecco, queste cose le puoi anche chiedere a un altro, oppure le puoi fare insieme a qualcun altro, ma non è lo stesso.
Leggendo In Esilio si percepisce che il libro è una finestra spalancata e un bosco. Con una finestra si possono fare solo alcune cose: ci si può mettere in mostra, tipo balcone di qualche palazzo, con raduno oceanico sottostante o senza; si può chiacchierare con il dirimpettaio, dei Mondiali o dell’offerta della settimana della Lidl, un contapassi a pile; si può calcolare cosa succede se uno si butta davanti al negozio del macellaio; oppure si può stare lì zitti, con un sorriso che contiene tutto e il contrario di tutto, e pensare alla vita, alle cazzate e alle cose essenziali, al passato e a qualche sogno tenace che resta, a dispetto di tutto. Rimane il bosco. E in un bosco si può solo scappare e nascondersi. Per fare l’amore con una donna o per evitare certa gente che ancora oggi domina le strade e le infesta. In entrambi i casi il bosco rappresenta la salvezza. Lo sapeva perfino Cappuccetto Rosso: il bosco è salvifico, perché il lupo è mille volte meno micidiale del cacciatore, e forse anche della nonna.
Le prime parole che incontriamo nel libro sono queste. Sono di Antonio Gramsci e sono tratte dai Quaderni del carcere. Se restiamo fedeli alla teoria di base, o meglio all’impressione immediata che questo sia un libro necessario, per l’autore e non solo, le prime parole non possono essere casuali né messe lì tanto per fare show. Siamo implicitamente invitati a ragionarci sopra, a sentirle dentro, confrontandole con ciò che percepiamo e con il mondo che siamo e che viviamo. La parola “crisi” in giapponese si scrive con due ideogrammi: uno significa “pericolo”, l’altro “opportunità”. Non conosco purtroppo l’idioma nipponico e non sono certo che l’affermazione sia esatta. Ma mi piace pensare che lo sia. Se non è una verità assoluta è, perlomeno, una verità poetica. E la poesia ha molto a che fare con questo libro. Questo libro la contiene, ma senza mai farla esondare nella palude melensa della retorica, del patetismo o di qualche rivolo di parole scontate e stantie. Simone Lenzi ha senso del ritmo e orecchio, anche nelle dita con cui scrive. Appena percepisce che la frase sta virando un po’ troppo verso il lirismo deteriore corregge la rotta come un abile marinaio del porto di Livorno. Con un’imprecazione e un colpo di timone, un cambio di rotta fatto di realtà nuda e cruda, di facce da marciapiede o da televisione che peggiorano all’istante la gastrite e ti fanno correre via a cercare un paio di confezioni giganti di Maalox.
L’epigrafe è tratta dai Quaderni del carcere. E questo libro ci dice, anzi ci ricorda, mostrandocelo, che il carcere non è una cosa lontana nel tempo e nello spazio. Non è un palazzone distante che non ci riguarda. Nel carcere ci siamo, tutti, ciascuno a suo modo, ogni giorno che campiamo. Sarebbe bello poter dire che non è colpa nostra e che siamo innocenti. In realtà nel carcere non ci siamo messi da soli, d’accordo, ma ogni giorno abbiamo consentito che aggiungessero uno strato di calce. Anzi, più di una volta abbiamo anche dato una mano, agevolando amabilmente chi ce lo costruiva attorno, con noi dentro a chiacchierare e a guardare “la storia dei ciccioni che non riescono più ad alzarsi dalla sedia. La storia dei nani che si amano (…) Delle reginette di bellezza assassinate nella provincia americana più profonda. La storia dei cuochi vagabondi che assaggiano una brodaglia in culo al mondo e cercano di spiegarti quanto è buona(…) La storia di quelli che si trasferiscono in Italia dall’Arkansas e scoprono che in Italia non usiamo l’asciugatrice per i panni, ma non importa, adoriamo questo Paese!” e mille altre meraviglie della nostra Mirabilandia globale.


Fino a che l’elenco non sfocia in una frase che interrompe il riso corrosivo e ci dice non solo quello che ci è toccato in sorte ma anche ciò che sentiamo, davvero, nel profondo. Ci dice come siamo, non solo ciò che abbiamo. Ci svela quello che alla fine siamo arrivati a volere: “La storia delle grandi invenzioni umane e la storia dell’universo, dei buchi neri, delle galassie. La storia dei file segreti della CIA, dei grandi complotti, della vita su Marte, delle civiltà aliene, la storia del mondo fra cent’anni, dopo l’Armageddon di cui si ha sempre più desiderio e sempre meno paura”. Eccoci qua. Come la lettera rubata di Edgar Allan Poe, in bella vista, nell’elenco delle amenità micidiali è presente un sunto della situazione e un progetto di fuga. Giunti a questo punto, sommersi fino al collo da oggetti e immagini tanto innocui e insulsi da risultare annichilenti, l’Armageddon tutto sommato diventa un Luna Park, e l’impressione è che pur di scappare dalla simpatica routine che si strozza saremmo disposti a mangiare, altrove, quintali di zucchero filato avvelenato. Purché, appunto, sia lontano, sia da qualche altra parte, sia forma e spazio di esilio vivibile. La prima frase dell’autore che incontriamo in questo libro, quella con cui ci viene incontro e ci accoglie è: “Questa non è una storia. È un invito a guardare di nuovo il cielo di notte, in estate, come si faceva da ragazzi, quando cercavamo di riconoscere il disegno delle costellazioni. Non è una storia, perché le storie le abbiamo viste già tutte in televisione, per tutte le sere di questa nostra prematura vecchiaia in cui abbiamo smesso di uscire a guardare il cielo d’estate e siamo rimasti seduti sul divano ad ascoltare, a osservare milioni di storie che ci scorrevano davanti”. Una decina di pagine oltre, dopo avere elencato una quantità di scene prive di senso e di bellezza di cui ci nutriamo e a cui veniamo dati in pasto, Lenzi ci offre una chiave, o meglio ci dice di più, aggiunge un indizio, un segnale lungo la litoranea piena di curve che ci conduce verso il sogno o verso uno spazio sgombro e silenzioso: “alla fine non restava altro che la fine stessa in un cielo immensamente vuoto. Ecco, questo è un invito a indovinare la fine di un cielo immensamente vuoto in una notte d’estate”.
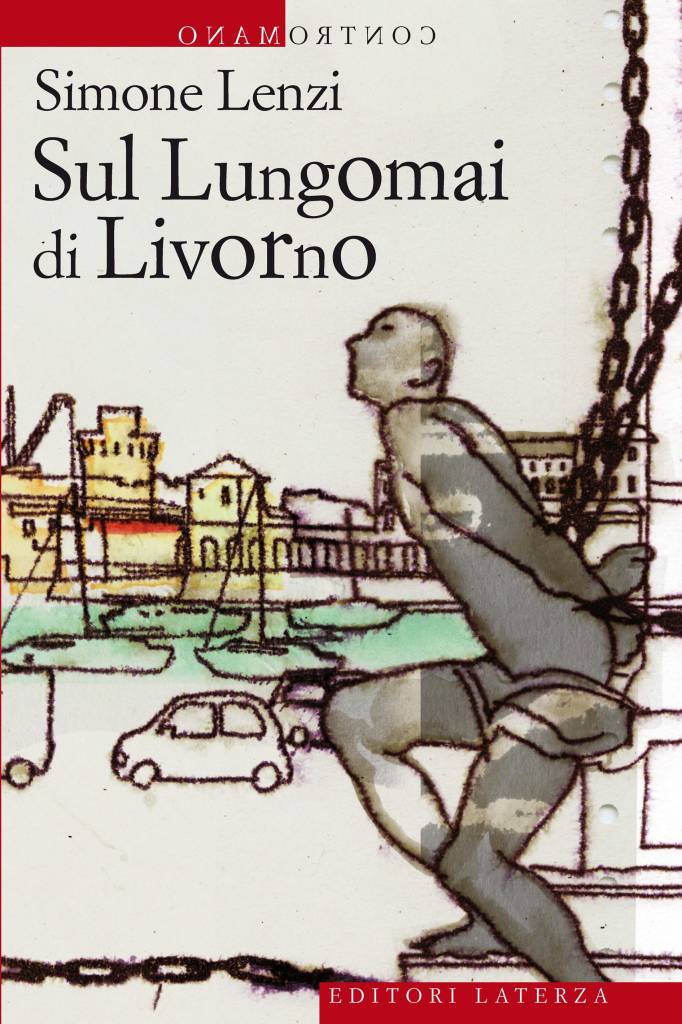
Poco oltre, altre due indicazioni generose, di non scarso rilievo, come a lasciare una traccia per poter essere seguito, se non raggiunto, lungo il cammino: “Io non so che fine faccio – scrive Lenzi – e neanche so dire esattamente quando ho cominciato a fare la fine che faccio. Ma sono certo che sto facendo una fine. D’altronde, è quasi più facile capire che fine fanno gli altri”. Voilà: si è, anche nella fuga, sulla via dell’esilio, inesorabilmente soli e inesorabilmente in compagnia. Solo che è più difficile vederci vivere, come diceva Luigi da Girgenti , quello dei Sei personaggi e delle Maschere nude.
È più difficile vedere la nostra stessa vita. Guardarla può voler dire rimanere risucchiati nell’abisso o in una risata sconfinata. Allora non resta che ragionare sulla mancanza di ragione che poi in fondo è il solo modo di sfuggire ai denti acuminati della logica, della consequenzialità: “Mi vengono in mente episodi apparentemente insignificanti, che forse non c’entrano l’uno con l’altro, ma che si presentano insieme alla memoria”, aggiunge. E qui entriamo in ballo noi. O meglio, tocca a noi provare ad accelerare il passo e cercare di cogliere un po’ più da vicino l’espressione di Lenzi, sempre a metà strada tra serietà e ironia; serissima l’ironia, e quanto mai amaramente ironica la serietà. Tocca a noi prendere tra le mani e soppesare quel vocabolo che sembra piccolo e accessorio e che invece è essenziale, nel paragrafo citato, nel libro intero e in tutta l’arte degna di tale nome. Il vocabolo formato mignon è quel “forse”. La parola quasi magica che ci fa rimuginare e pensare che, in realtà, gli episodi apparentemente insignificanti a ben vedere non sono insignificanti per nulla, e c’entrano, anzi “ci combinano”, l’uno con l’altro, e non solo l’uno con l’altro ma anche con noi, sì, noi, che inseguiamo a qualche passo di distanza, smarriti nel nostro personale percorso e con addosso la calce della nostra individuale galera di un colore appena diverso.

Non avrebbe senso scrivere un libro che escluda chi lo legge, così come non avrebbe senso scrivere un libro in cui non venga messo, seppure tra filtri e dighe, qualcosa dell’autore, la parte più vera. E allora, dietro il filtro metaforico della storia di Lot che lascia Sodoma con moglie e figlie, ecco la frase che nasce dalla parte nuda e esposta, là dove ogni pensiero scava e fa male e bene, e uccide o salva sul serio: “Però una cosa in comune con la storia di Lot c’è, dissi a mia moglie, ed è che io devo andarmene sul serio da qui. Quindi bada bene che se ti volgerai indietro a rimpiangere la città, verrai trasformata in una statua di sale e io ti lascerò lì (…) Pensiamoci bene: devo andare in esilio, ma se tu non vuoi, possiamo anche non farne di niente. E tanto ormai esco di casa cinque minuti. Posso continuare”. Anche in questo caso l’espressione di Lenzi, sia della parola che dei lineamenti del viso che intuiamo, è di precisione millimetrica. Non dice “voglio andare in esilio”. Dice devo. E nello spazio che separa questi due verbi c’è tutto il mondo, il suo e il nostro. Si perché anche molti di noi ormai escono di casa cinque minuti al giorno. E anche molti di noi, a questo punto, non hanno una vita sociale neppure su Facebook.
L’umorismo di Lenzi non fa mai sconti. Non assomiglia a quello del guascone del bar che urla e sbraita e ti prende a pacche sulle spalle mentre ti spinge verso il bancone raccontandoti una specie di barzelletta sconclusionata di cui tutto sommato capisci poco e ti frega ancora di meno. L’umorismo di Lenzi, al contrario, ti fa ridere quel tanto che basta per farti capire che da ridere c’è poco o niente. E quella che ti racconta Lenzi non è una barzelletta, almeno che non si voglia considerare barzelletta la vita. Ma forse è più corretto definirla freddura, o meglio ancora fregatura. Lenzi non ti trascina verso alcun balcone, non cerca applausi e risate a cuor leggero, assordanti e stordenti. Parla, piuttosto, con voce nitida ma senza urlare. Per farsi ascoltare solo da chi è realmente interessato, chi si ritrova nel tono, nella trama, nelle maglie della stessa rete, della stessa inferriata della stessa prigione. Sembra volerci dire, voi ridete, ma la mia voglia di fuggire è vera e nasce da cose che sono diverse dalle vostre, anche se in fondo vogliamo scappare tutti. Io non vi voglio insegnare niente, tranne una storia che non è una storia e che è tutto ciò che ho. La condivido con chi come me pensa che ognuno è soltanto se stesso ma è anche tutti gli altri, tutti i sentieri che attraversano altri terreni ma in fondo nascono dalla stessa palude e sognano la stessa radura più sana e pulita.

Per far questo, lo strumento di Lenzi, anche nel senso musicale del termine, qui in queste pagine è la capacità di modulare i registri, passando dal colto al quotidiano, non per scelta, per necessità. Perché la complessità del mondo richiede di saper cogliere e accogliere dentro di sé il sublime, l’etereo e il tangibile, ciò che si tocca con le mani e fa venire i calli. Non è un caso che il libro per eccellenza, la bussola della mente e del cuore consigliata in questo libro, non è narrativa, non è un saggio, non è poesia. È un catalogo di ferramenta. Con meravigliose dettagliatissime illustrazioni. Contiene forbici da giardino, erpici e rastrelli. Contiene forse in quei metalli il segreto “della malinconia silenziosa di cui nessuno saprebbe di fatto rendere ragione”. Contiene una guida pratica per tentare di salvarci, in attesa della fuga risolutiva. Un erpice da giardino, la nuda terra profumata e un riso autoironico nascosto da qualche parte nei meandri del cervello. Come quando al protagonista capita di leggere: “Dimi se mai sentisti nuove de’ Lenzi, chi e dov’egli è, che mai vidi più tristo huomo”. Zappare la terra di un orto e pensare ad un proprio antenato definito senza mezzi termini “uomo dall’animo torvo e incline al disprezzo, forse perfino malvagio”. Il magico catalogo-breviario Hardware and General Goods for the Autumn 1938 e una discreta dose di autoironia forse possono tenerci in vita fino al momento della Grande Fuga.

Così come forse ci salva la capacità di essere multiformi, camaleontici e tenaci. Come questo romanzo, rapsodico e pieno di raptus, sempre bene orchestrati, ottimamente dosati e ritmati. La frase precedente è il trionfo della lettera erre. Aggiungo anche rock, che ci sta molto bene, non guasta mai.
Il romanzo di Lenzi è nato contemporaneo e lo diventa, per gli avvenimenti recenti, sempre di più. È attuale per natura intrinseca e per destino. Si potrebbe dire per buona sorte, se gli avvenimenti recenti fossero almeno in qualche caso gradevoli e propizi. Ma ha la caratteristica di parlare della storia del nostro Paese dando alle miserie limitate dei personaggi politici che descrive un respiro in qualche misura più ampio. Non riesce a renderli meno meschini però li trasforma almeno in paradigmi di qualcosa che va al di là del loro limitato orticello, così sterile che neppure gli erpici del magico catalogo Hardware and General Goods riuscirebbe a rendere fertile.
In esilio alterna realtà e visionarietà, ma anche quest’ultima è concretissima, in qualche modo premonitrice, senza pretendere di essere profetica o di indicare panacee. Ci fa vedere come siamo, proprio perché non pretende di ritrarre nessuno, se non una storia senza storia che tuttavia sa di autentico perché contiene il vero e il fittizio, la verità e l’incubo di cui sono fatte le nostre teste, i nostri gesti, le vite che abbiamo o che sogniamo di avere. Che poi è la stessa cosa.

Già, il sogno. Con amara e salvifica lucidità ci viene detto che colui che ha vissuto e scritto queste pagine ha come sogno prioritario quello di andare in esilio. Non ci viene detto dove né come. Ma poco importa. In fondo non è diverso dal sogno di ognuno di noi. Ci viene suggerito, tra le righe, cosa portare con noi: una buona quantità di “forse”. Vocabolo che, non a caso, domina il libro ed anche il finale del libro, aperto come non mai. Tanti forse e nessuna certezza, nessun dogma, nessuna coscienza della superiorità e di qualche missione eccezionale. E magari un buon libro. Un catalogo di ferramenta del 1938 oppure una storia senza storia in cui ciascun migrante della vita può riconoscersi trovando magari in un istante la forza di proseguire fino a qualche sponda, a qualche traccia di umanità.
Condividi




